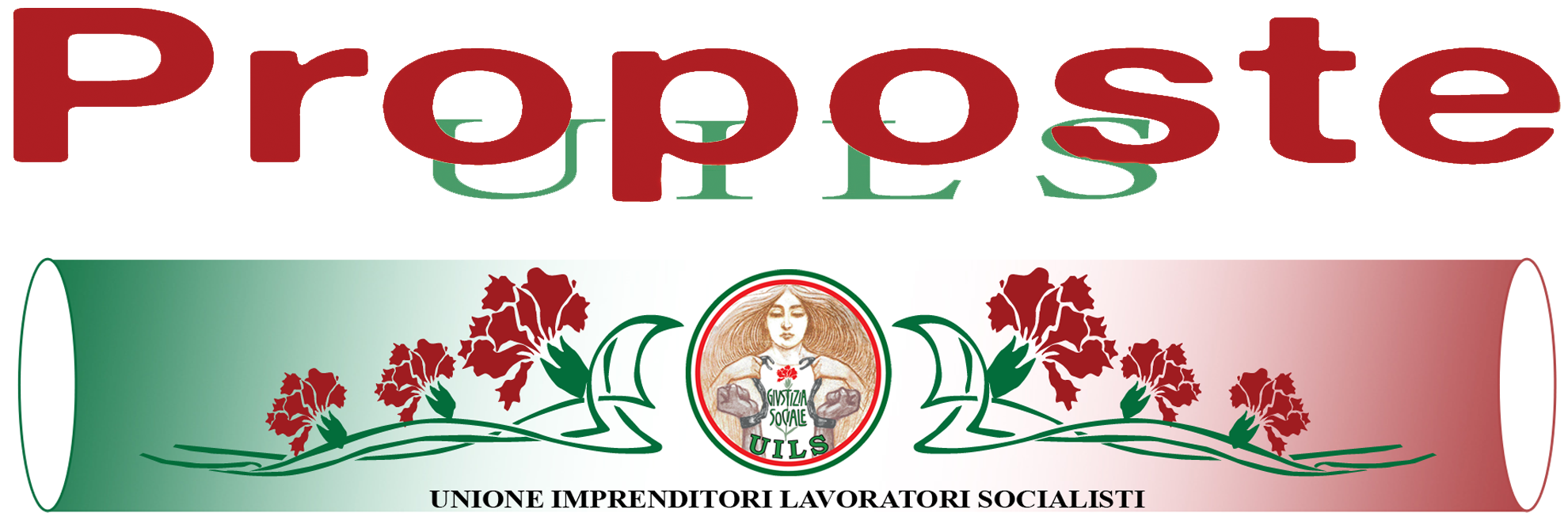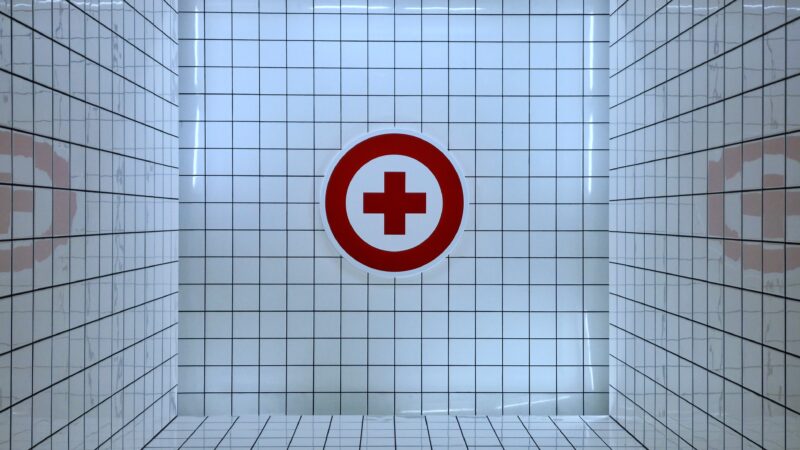Le catene alla radice del male

La violenza contro le donne passa dalla violenza economica
“Io vorrei che tutti cominciassimo a sognare e progettare un mondo diverso. Un mondo più giusto. Un mondo di uomini e donne più felici e più fedeli a sé stessi.”
Sono forti e concise le parole che Chimamanda Ngozi Adichie ci consegna con il suo saggio “Dovremmo essere tutti femministi”. E altrettanto diretti sono stati gli interventi della conferenza La violenza economica, del progetto Giovani Pensatori del Centro Internazionale Insubrico dell’Università degli Studi dell’Insubria. Sabrina Ditaranto, magistrata della Procura del Tribunale per i Minorenni di Milano, Valentina Grassi, portavoce di Amnesty International e Stefania Passiu, avvocata civilista dell’Associazione SiCura, hanno trasmesso alla platea la portata della violenza economica contro le donne nel fenomeno multiforme della violenza domestica.
Di questo tipo di violenza si parla troppo poco – ha affermato Stefania Barile, coordinatrice del tavolo di lavoro – perché si nasconde questo fenomeno, certo connesso alla violenza psicologica, dietro a delle paratie di cura e di tutela della donna che in realtà le tolgono l’autonomia e l’indipendenza per poi arrivare ad un’escalation di violenza.
L’obiettivo è quello di arrivare ad un ripensamento delle relazioni e alla consapevolezza che l’indipendenza economica è un “traguardo” fondamentale per tutte le donne. Ma come iniziare a progettare un mondo diverso?
La dott.ssa Ditaranto ritiene fondamentale la trasversalità di genere degli interlocutori. “Dobbiamo aprire questo tema agli uomini, perché anch’essi comprendano i messaggi sotterranei della violenza di genere e siano anche loro capaci di individuare il problema, che sia dentro di sé o sia fuori da sé.”
Senza questo passaggio fondamentale non si può costruire una società dove la violenza di genere costituisca un caso eccezionale. E lunga è la strada ancora da percorre. La violenza economica è una categoria entrata molto di recente nell’ordinamento. Con la ratifica della Convenzione di Istanbul da parte dell’Italia nel 2013 e la sua entrata in vigore il 1 agosto 2014.
È un tipo di maltrattamento, spesso alla base di violenze successive, di tipo fisico e sessuale, che assomiglia alla violenza psicologica, riconosciuta e definita nella Convenzione, ma che è raramente punibile di per sé. Esso si può indirizzare ai beni esistenti della vittima, così come al patrimonio potenziale, per esempio inducendola, anche in modo suadente, a non lavorare.
Tra le forme di violenza economica è stato annoverato l’impedimento e il divieto di attingere al conto corrente o di conoscere l’entità delle entrate della famiglia, “una società in cui, nella normalità, le persone si uniscono e vanno in un’unica direzione e dove non devono mai esserci disequilibrio e prevaricazione, oggi ritenuti reati di maltrattamento”.
Questioni di frequente poco chiare alle donne stesse, spinte così ad accettare condizioni sfavorevoli o a rinunciare alle proprie carriere, perché spesso il lavoro è vissuto come mero ritorno economico. “Quando il lavoro è ben altro, è possibilità di scelta”.
E sono molte le donne che cadono in gabbie per nulla dorate dalle quali è poi difficile uscire. Come ha ricordato l’avv. Stefania Passiu, molte donne non ascoltate diventano “vittime perdute”. Che rientrano nel ciclo della violenza, dove la dipendenza economica rende tutto più difficile.
Per l’avvocato, l’educazione economica e finanziaria “è un elemento fondamentale per prevenire la violenza. Ma lo è anche quando le donne prendono il coraggio di uscirne e denunciare”. Gli strumenti di protezione infatti, la Convenzione di Istanbul e la nostra Costituzione, possono sì tutelare da un punto di vista giuridico, ma non riescono ancora a scardinare la violenza di genere, che ha profonde radici culturali. Basti pensare al caso della legge contro lo stupro, che solo dal 1996 configura la violenza carnale come delitto contro la persona.
Si tratta di radici che affondano in una concezione patriarcale ai nostri giorni intollerabile, ma che è ancora uno scenario costante. In Italia una donna su due non lavora. E quando lavora è pagata meno di un uomo, a causa del gender pay gap. Grave fenomeno che ha portato alla recente direttiva della Comunità Europea, la n. 970 del maggio 2023, che introduce l’obbligo della trasparenza retributiva per tutti i datori di lavoro, pubblici e privati.
La disparità colpisce anche le professioni più remunerate, contando una differenza salariale oraria media che raggiunge circa il 23%. Divario che contribuirà anche a quello pensionistico, che secondo i dati Eurostat del 2020, si attesta per le donne lavoratrici intorno al 30%. Inoltre è la segregazione lavorativa, ovvero la relegazione delle donne ai lavori meno retribuiti, a determinare la maggiore povertà di genere. Senza contare il carico di cura familiare, che grava su di loro storicamente.
Ci sono dei dati concreti che ci mettono di fronte alla realtà – ha continuato Valentina Grassi di Amnesty International – e purtroppo ci sono delle situazioni delle quali non ci si capacita. Con i femminicidi, l’estremo atto di violenza, si hanno immense perdite, ci ricorda la portavoce. Insieme alla madre uccisa, i figli perdono anche il padre, che viene arrestato o si suicida. Sono bambini invisibili che finiscono nel limbo della vergogna. Vittime che la società spesso giudica e manca di tutelare. E per spezzare le catene della violenza è necessario il risveglio degli adulti del futuro. In loro deve nascere la precisa consapevolezza che combattendo le discriminazioni contro le donne, la collettività potrà fiorire. Anche economicamente.